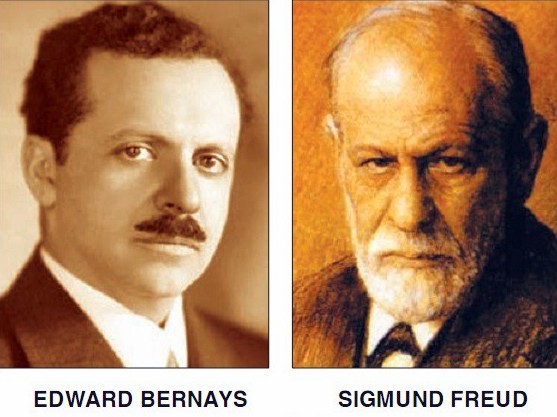Ora, diamo per ammesso che le riviste gastronomiche sono quelle scritte dai giornalisti gastronomici, e che questi abbiano sufficiente competenza in materia, almeno quanto ne dovrebbero avere i loro colleghi che si occupano di cronaca, moda, economia, salute, sport e spettacolo. Se così è, ad ognuno di questi compete la precisa funzione di svolgere professionalmente opera di mediazione tra la fonte e il destinatario dell’informazione. Conseguentemente, in qualunque settore delle numerose attività umane sia destinato a svolgere quest’opera, il professionista dovrà assumersi i compiti inerenti alla ricerca, all’acquisizione, alla verifica della notizia e magari alla sua analisi critica. Questo all’incirca si legge in un’autorevole pubblicazione sul mestiere di giornalista, e lo stesso dovrebbe valere per chi scrive di cibi e vini, di cucine e ristoranti.
Dunque, se questo non fosse solo un percorso deontologico ideale, per questa via (di principio) al lettore arriverebbe la notizia che il libero giudizio del giornalista, nella piena autonomia del suo esercizio professionale, ritiene meritevole di essere comunicata. Certo, a stabilire quale sia questo valore ci vorrebbero, come comunemente si dice, persone oneste e preparate. E non è un problema da niente!
Prendiamo il discorso alla larga, e proviamo a vedere cosa accade dell’informazione nella stampa in generale.
Se le cose stessero come abbiamo detto sopra, su quotidiani e riviste sapremmo di più delle tragiche condizioni delle periferie urbane delle grandi città, che non dell’arrivo di Madonna per la prima del suo film a Roma e quel che ne è seguito.
E` evidente che gli effetti delle sperequazioni sociali, quando la loro tragicità non assumano carattere di spettacolarità, fanno meno frequentemente notizia dei capricci di una diva italoamericana; il motivo sta tutto nelle risorse promozionali investite sulla figura della Madonna/Ciccone, capaci di costruire un tale vantaggio competitivo intorno alla sua persona, da arrivare a fare delle sue spettacolari stravaganze un valore aggiunto al prodotto (Madonna). Insomma, fuori dalla terminologia del marketing, parlare di Madonna è un buon investimento; lo è per lei, per il produttore del film, per l’industria cinematografica americana, per i suoi importatori italiani, per l’economia statunitense e, finalmente, per il mantenimento degli equilibri politico-economici del mondo intero.
In assenza di motivazioni politiche o di probabili speculazioni edilizie, essere informati sul degrado dei quartieri suburbani, pur avendo un indubitabile carattere d’urgenza sociale, non è comunque una notizia che “paga”.
Ecco, il concetto generale è che la notizia per apparire, essere visibile, in una parola “esistere” come tale, deve essere pagata; come generalmente si dice di giornali e riviste che devono esserlo ancora prima di arrivare in edicola.
D’accordo, finora gli esempi potranno apparire un po` esagerati, ma quello che vogliamo dire è un’ovvietà: ciò che merita un’immagine televisiva, una parola alla radio, un trafiletto sul quotidiano o un articolo su un periodico, è quello che si fa notizia in forza d’interessi non tutti motivati dal valore informativo che un professionista dell’informazione, in piena autonomia, ritiene di assegnarle.
Ma veniamo ora ad un esempio relativo alla cosiddetta stampa specializzata.
Alcuni enti locali al sud hanno realizzato un progetto per riqualificare per un uso culturale e turistico alcuni tratti dell’antiche vie della transumanza, con la creazione di piste ciclabili, zone di sosta, aree archeologiche attrezzate e protette.
Per la sua realizzazione il progetto ha ottenuto i finanziamenti della CEE. Da questa notizia, un pubblicista curioso redige un’articolata proposta all’indirizzo di una nota rivista che si occupa di ambiente e natura per un servizio su un percorso cicloturistico (mai prima tentato né immaginato) su questi antichi tratturi.
La proposta, pur avendo riscosso attenzione per la sua significativa utilità (segnalare la possibilità per un turismo sostenibile e le conseguenti opportunità per l’indotto), viene tuttavia preventivamente sottoposta, per così dire, a un’indagine di “fattibilità”. La redazione si attiva, e cioè`: viene interpellata una famosa marca di biciclette, che declina l’invito a dare un “suo contributo partecipativo” per comparire con i suoi prodotti nelle foto a corredo del pezzo; si contattano gli enti locali dei paesi attraversati, che ringraziano dell’attenzione, ma anche loro, per disinteresse o ragioni di bilancio o altro, non “partecipano”. Morale: l’articolo non si fa, e la notizia che al sud alcuni comuni si siano mossi per valorizzare il loro territorio recuperando antiche vie pastorali per una funzione turistica non passa.
Potrebbe andare diversamente nella stampa enogastronomica, dove ancora più pesantemente è la direzione commerciale a decidere delle scelte editoriali? No. Esempio. Se l’editrice a cui appartiene una testata giornalistica ritiene di essere concorrente di un’altra che si fa promotrice di interessanti iniziative, queste non potranno essere comunque menzionate sulla rivista dell’editrice concorrente. Ugualmente, se gli inserzionisti della rivista sono grandi marche di un determinato settore merceologico, per non disgustarle non si potrà scrivere del buon lavoro svolto da una piccola azienda artigianale nello stesso settore.
Questo deve scandalizzarci? Certo che no. Tuttavia, oltre ai condizionamenti imposti dalla legittima tutela degli interessi dell’editore “di riferimento”, altri ve ne sono, legati direttamente alla raccolta di pubblicità`.
Ora, dal momento che la condizione essenziale per la sopravvivenza di quotidiani e periodici di qualsivoglia parte e natura è la raccolta di una pubblicità di buon livello, ogni responsabile editoriale s’industria come meglio può a conquistare la fiducia dei migliori inserzionisti; fiducia che è legata a sua volta alla buona diffusione della rivista, vale a dire alla sua tiratura. È quanto accade naturalmente anche per le quelle che trattano di vini e cucina. Questa ottima ragione, infatti, le obbliga a trattare temi e argomenti capaci di interessare un pubblico potenzialmente (sociologicamente e culturalmente) indirizzato all’acquisto di quei determinati beni di consumo pubblicizzati sulla rivista. Esemplificando: fornire l’indirizzo del macellaio spettatore delle intemperanze comportamentali dell’onorevole Sgarbi; segnalare il fornitore ufficiale di caffè di casa Agnelli o recensire il pizzicagnolo di fiducia del cavalier Berlusconi, sono notizie capaci di coinvolgere quella fascia di lettori ansiosi di acquisire prestigio attraverso l’emulazione nella spesa dei grandi; che si vedrebbe bene al volante di un monumentale fuoristrada, vestita in abitini con grandi firme o calzata negli esclusivi mocassini da barca reclamizzati sullo stesso giornale.
Volendo rischiare un’analisi di cosa concorra all’ottenimento di un buon introito pubblicitario, e dunque al sicuro successo editoriale di una rivista di cucina, nell’ordine diremmo: la pubblicità redazionale e quella sommersa; le magnifiche foto dei piatti; le ricette alla moda; le recensioni di ristoranti e prodotti che “fanno tendenza”; i servizi sulle predilezioni gastronomiche di personaggi famosi.
Così operando si evita di passare alla storia, ma alla cassa perlomeno ci si arriva. Ci riferiamo al fulminante enunciato di un rampante giornalista al suo insediamento come direttore di una nota rivista di cucina: “Non vogliamo passare alla storia, vogliamo passare alla cassa”. Da allora, ancora si attende una sintesi più lapidaria e trasparente di una linea editoriale studiata per vincere.
Ma questa è soltanto una base minima, uno stadio elementare appena accettabile in un programma editoriale di una rivista che voglia avere una qualche possibilità di riuscita economica sul mercato.
In molte testate la politica commerciale nel reperimento di fondi è più palese; altro che la cosiddetta pubblicità occulta televisiva! In queste, l’acquisto di spazi pubblicitari da parte di aziende e produttori diventa la condizione imprescindibile perché si scriva di loro e dei loro prodotti.
In tutto questo sistema di interessi, il giornalista è relegato al ruolo di confezionatore di pezzi agiografici su commissione o di comunicati aziendali; del resto, la sua assunzione – ma anche la sua disoccupazione – sono spesso legati a pressioni fatte sulla rivista da qualche importante inserzionista. Perché accade – ed è accaduto – che un inserzionista abbia imposto alla proprietà del giornale di scegliere fra la sua pubblicità e il mantenimento di un giornalista indesiderato. La proprietà ha preferito tenersi l’inserzionista e il collaboratore ha cessato la sua collaborazione.
Si dirà, in qualunque modo il nostro eroe si sia guadagnato da lavorare, il suo compenso non è forse pagato dagli inserzionisti o dalle aziende citate nei suoi pezzi? Dunque perché meravigliarsi? È una pratica frequente che la direzione assegni al collaboratore il compito di tessere l’encomio di un intraprendente imbottigliatore di pessimo vino – disposto però all’acquisto di uno spazio pubblicitario per promuoverlo – con un servizio elogiativo dei suoi prodotti; laddove l’onesto produttore di qualità, ma con una cifra limitata da investire nella promozione, difficilmente arriverà a conquistarsi una visibilità.
In una parola, l’impressione è quella di una progressiva scomparsa dell’informazione, sostituita in maniera crescente da una forma più o meno dichiarata di comunicazione aziendale.
Quando ancora (forse) esisteva una generazione capace di rovinosi slanci ideali, vigeva un’affermazione di principio che diceva: né servi né padroni. Ora, l’aggiornamento vorrebbe che si dicesse: né venditori né venduti.
Tuttavia, in questa alternativa, fra l’essere usati per interessi commerciali e il diventare imprenditori di se stessi o – come molti giornalisti sono passati a fare –comprando a loro volta il lavoro di altri, potrebbe esserci una terza via: quella di contrattare il proprio asservimento secondo le leggi del mercato.
Concedendo che ormai l’informazione è assimilata alla pubblicità redazionale o a comunicati su aziende e prodotti, la nostra modesta proposta è che il giornalista – pubblicista o semplice collaboratore (le categorie meno protette) – venga informato su chi serve e sulla natura (e misura) della sua dipendenza all’editore di riferimento o ai maggiori inserzionisti dell’azienda a cui presta la sua opera; che sappia cioè di quali spazi d’autonomia dispone nell’esercizio della sua professione.
L’editore dica chiaramente: la nostra testata dipende dai finanziamenti di Tizio e di Caio, si eviti dunque di parlare di questo argomento o prodotto, dite pure ogni bene di quest’altro, potete criticare liberamente ciò che resta. Una volta che sia stato informato su chi paga e quanto per farlo lavorare, il nostro potrà, attraverso una trattativa privata simile in tutto a quella di qualunque professionista autonomo, stabilire, in accordo con la proprietà della pubblicazione a cui presta la sua opera, una cifra congrua per la sua parzialità nella redazione di notizie, articoli e servizi.
Non è più giusto così, piuttosto che continuare ad illudersi di star facendo dell’informazione?
Giuseppe Lo Russo, 1996